Il grande Napoleone era da poco spirato che le prime crepe si insinuarono nel grande impero che aveva creato. Il nuovo sovrano aveva poco più di trent’anni ma ne dimostrava almeno dieci di più. Grasso e abulico, aveva dimostrato scarsissimo interesse per gli affari di Stato e ancor meno per l’esercito. Vivere troppo nell’ombra di un padre ingombrante e spesso assente aveva creato un rapporto di dipendenza con la madre che ne aveva minato le capacità di comando, lasciando un sovrano debole ed irresoluto sul trono.
Proprio come ai tempi di Basileios II, morto senza eredi maschi di spessore, ancora una volta l’Impero Romano si trovava senza una guida. E quelli furono anni in cui un imperatore forte era proprio necessario.
I primi problemi, infatti, giunsero dalla Francia. Nel 1838, a Nantes, i bretoni e i vandeani tornarono a ribellarsi. A capeggiarli vi era un fantomatico erede di Charles X, che si fece incoronare nella cattedrale di Saint-Pierre-et-Saint-Paul il 4 Febbraio. Questo fatto fece scoppiare una rivolta anche a Parigi, che insorse e proclamò, invece, una Repubblica. Questa era divisa tra le frange moderate liberali e cristiane, che sarebbero state disposte ad accettare anche un sovrano costituzionale, e quelle socialiste e anarchiche, che ambivano ad un sistema democratico assoluto.
Le truppe romane nella zona intervennero lentamente e in modo poco deciso, perdendo centri importanti come Orléans, Rheims e Caen. Entro l’estate i ribelli avevano ottenuto numerose armi, uniformi e polvere da sparo impadronendosi dei depositi imperiali del nord, oltre che godere di ingenti aiuti giunti dalla Gran Bretagna.
Napoleone II rimase paralizzato perché in quei mesi subì un attentato e dovette reprimere una congiura di militari che lo ritenevano inadatto a regnare. Nella domenica di Pasqua ordinò l’attacco contro un gruppo di ufficiali di esercito e marina che avevano ottenuto il sostegno di alcuni reggimenti delle Guardie Imperiali. L’operazione degenerò quando permise il saccheggio delle case dei presunti traditori, che si allargò nel resto di Costantinopoli con i soldati che ne divennero i padroni per quasi tre giorni.
Il bilancio fu di 2.500 morti e oltre duecento edifici distrutti o danneggiati, cosa che gli inimicò fortemente il popolo.
La crisi nel centro dell’impero indebolì ancora di più le frontiere e diede forza ai suoi avversari. Joseph II d’Habsburg, ora ridotto al rango di sovrano d’Austria all’interno dello Stato cliente della Germania Magna, si alleò con l’anziano Friedrich Wilhelm III di Prussia per scardinare l’assetto creato da Napoleone I.

L’idea era quella di creare una doppia confederazione, quella della Germania del Nord, a guida prussiana e protestante, e quella della Germania del Sud, a guida austriaca ed ecumenica.
Nel giugno del 1838 i primi occuparono tutto il resto dell’Hannover, Amburgo, Brema, l’Oldenburg, il Mecklenburg e buona parte della Westphalia. Le truppe asburgiche, invece, dilagarono in Baviera, nel Palatinato, nel Baden-Württemberg e in Sassonia.
Le truppe confederali, guidate dal proconsul romano Andronikos Phokas, riuscirono ad ottenere diversi successi, ma via via che parti della Germania cadevano in mani nemiche le loro truppe perdevano lo spirito combattivo e spesso disertavano. Phokas riuscì comunque a mantenere nelle sue mani diverse fortezze nella parte centrale, oltre che le città di Norimberga e Francoforte, e preservò l’indipendenza della Sassonia e della Baviera, che rimasero alleate dell’Impero Romano per paura di venire fagocitate dalle due potenze tedesche.
Dopo la battaglia di Erfurt, culminata in una vittoria campale romana, gli alleati proposero una tregua sulla base dell’uti possidetis e della convocazione di una conferenza trilaterale tra Praga, Berlino e Costantinopoli per un nuovo assetto, più bilanciato, della Germania. Napoleone II, consigliato dal suo nuovo primo ministro Theodoros Doukas, decise di accettare, in modo da spostare truppe e risorse in Polonia, a sua volta sotto pressione da parte della Russia.
Questa, infatti, rivendicava alcune città di confine in Lituania e sul Mar Nero. L’arrivo, però, di 40.000 tedeschi di Phokas nella regione fece desistere gli tzar dal far scoppiare una guerra aperta.
Il prezzo da pagare, però, fu la fine dell’egemonia romana sulla Germania. Tra l’altro, nei primi mesi del 1839, l’Olanda si proclamò come Stato indipendente, facendo rinascere l’antica repubblica e cacciando la famiglia reale degli Orange, che erano diventati partigiani di Costantinopoli come sovrani del paese. Le truppe romane erano troppo lontane per evitare questa secessione, sostenuta ancora una volta dalla marina e dal denaro britannico. Il governo appena insediato ad Amsterdam proclamò, inoltre, di non far parte di alcuna istituzione tedesca, puntando a riaprire i commerci con l’Estremo Oriente.
Mentre i delegati di Napoleone II cercavano di trovare un accordo con austriaci e prussiani per un riassetto della Germania, le truppe imperiali muovevano per reprimere la rivolta francese. Ben 100.000 soldati vennero inviati contro i “realisti”, e quasi altrettanti contro i “repubblicani”, ma i risultati stentavano ad arrivare. Le legioni trionfavano sul campo ma poi si impantanavano in assedi e, soprattutto, venivano indebolite da una costante guerriglia.
Le repressioni peggioravano via via la situazione e, alla fine, i comandanti decisero di evacuare tutto il paese a sud della Loira, mantenendo come basi avanzate le città di Poitiers e di Bourges.
A questo punto arrivò il colpo di grazia. Il 12 Luglio del 1839 arrivò una lettera congiunta, controfirmata dai sovrani di Gran Bretagna, Russia, Austria e Prussia, nella quale si ingiungeva la convocazione di una conferenza internazionale per ristabilire una pace duratura sul continente, rivedendo esplicitamente i precedenti trattati imposti con il ferro e con il sangue da Napoleone I. In caso contrario, sarebbe stata la guerra.

Napoleone II dimostrò il suo irresoluto carattere e tergiversò senza prendere una decisione. Al contempo, però, non mobilitò neanche gli eserciti, preparandosi al conflitto contro un’eventuale coalizione. Così facendo mise in serio rischio tutta la delicata architettura innalzata da suo padre.
I russi, come mezzo di pressione, invasero in agosto l’Ucraina, occupandone gran parte prima dell’inverno. I britannici fecero sbarcare 30.000 giubbe rosse in Normandia, occuparono alcune isole nei Caraibi e iniziarono a soffiare sui venti di ribellione e autonomia delle colonie di Colombia.
Prussia e Austria strinsero infine d’assedio Norimberga, sede del sempre più debole regime di Phokas.
Alla fine Napoleone II accettò i termini degli avversari, e venne deciso di convocare la conferenza per la primavera successiva, nel 1840. Questa decisione portò a dei moti nella capitale, durante i quali alcuni capi ribelli proclamarono la Repubblica. Il sovrano scappò a Tessalonica e per due mesi Costantinopoli rimase in mano ai rivoltosi, che instaurarono un regime di puro terrore. Solo in Gennaio vennero radunate abbastanza truppe fedeli per ripristinare l’ordine, che venne ottenuto dopo intensi combattimenti strada per strada e la morte di 8.000 cittadini. La cosiddetta “Repubblica dell’Inverno”, guidata da Ioannes Stavropoulos, un manovale del porto che aveva dimostrato insolite doti di capo, era finita in un bagno di sangue.
Questo fatto portò Napoleone II a revocare la Costituzione e tornare all’autocrazia assoluta. Questo atteggiamento venne ben visto dalla Russia, che in segno di appoggio restituì l’Ucraina prima dell’inizio delle trattative che si sarebbero tenute nel cuore del continente.
La Conferenza di Vienna, che ospitò i lavori di duecento delegati giunti da tutta Europa, stabilì, citando le parole dell’introduzione del documento finale: “Un nuovo ordine europeo, al fine di mantenere una pace duratura tra tutti i suoi popoli”.

Nello specifico veniva riconosciuta l’indipendenza dell’Olanda e della Francia, quest’ultima ridotta al solo nord del paese, oltretutto in piena guerra civile tra realisti e repubblicani. Tutti i governi stabilirono congiuntamente che la forma di governo della Francia sarebbe stata una monarchia assoluta, sotto la guida di Charles XI, schierandosi quindi contro i temuti repubblicani di Parigi.
In Germania veniva soppressa la Confederazione della Germania Magna, sostituita dalla Norddeutscher Bund a settentrione e dalla Suddeutcher Bund a meridione, la prima a guida prussiana e la seconda a guida austriaca. La Sassonia e la Baviera, per quanto facenti parte di questi sistemi, la prima nel nord e la seconda del sud, mantenevano un certo margine di indipendenza e un’alleanza difensiva con Costantinopoli.
La Polonia dovette cedere buona parte della Bessarabia alla Russia, che coronava il sogno di avere finalmente un grande porto sul Mar Nero grazie all’acquisizione di Odessa. I britannici, paghi di aver indebolito l’egemonia romana sul continente, non chiesero alcun compenso territoriale, ma si proclamarono garanti del nuovo status quo.
Eppure il drastico e repentino indebolimento dell’Impero Romano, unito agli epocali mutamenti sociali determinati dall’industrializzazione del continente e alla nascita della classe operaia, determinarono il successivo decennio di grandi risolte di ispirazione talvolta borghese e talvolta socialista.
Stava sviluppandosi infatti quella corrente di pensiero che verrà conosciuta in seguito come Romanticismo, tutta incentrata sulla riscoperta delle antiche origini dei popoli d’Europa. In Italia, culla dell’Impero Romano, rivissero paradossalmente i fasti del periodo comunale, con la celebrazione delle Repubbliche di Venezia, di Genova, di Firenze e perfino di quella Ambrosiana. Nella penisola iberica portoghesi e catalani recuperarono il ricordo dei tempi in cui governavano terre al di là del mare e perfino in Sicilia e Sardegna iniziarono a svilupparsi società segrete dedite alla creazione di nuovi Stati indipendenti.
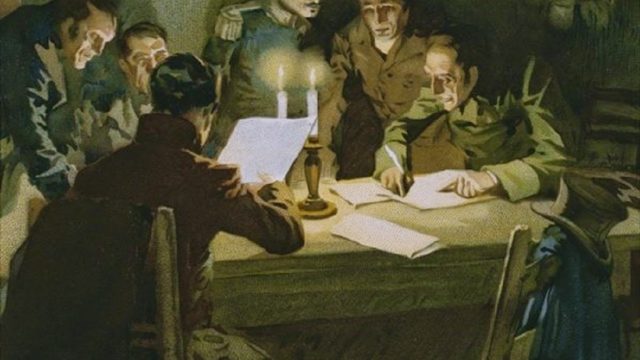
Un abile imperatore sarebbe riuscito a temperare gli animi, dosando il dialogo e le riforme con la giusta dose di repressione, ma Napoleone II non era quel tipo di uomo. Affidò buona parte degli incarichi di governo alla madre Eudoxia Komnena Palaiologa e alla zia, Paolina Bonaparte, sposata con l’ambizioso generale Gioacchino Murat, ormai quasi ottantenne, che si era guadagnato i gradi servendo contro i suoi ex compatrioti nelle guerre del grande padre.
Il trio governò l’Impero Romano per i successivi otto anni, in cui il debito pubblico aumentò a dismisura e si giunse quasi alla bancarotta nel 1846. Una serie di sfortunate iniziative coloniali in Indonesia e Indocina ammaccarono ancora di più il prestigio della monarchia e, nei due anni successivi, le morti in rapida successione di tutti e tre – ad ultimo Eudoxia, nel gennaio del 1848 – fecero crollare anche quel poco di stabilità rimasta.
Nel marzo dello stesso anno scoppiò quella che passò alla storia come l’Alba delle Nazioni. Dopo dieci anni di guerre civili, infine, in Francia aveva vinto la Repubblica. Charles XI era stato decapitato sulla pubblica piazza e la sua testa infissa su di una picca davanti al Palazzo della Tuileries. La corrente socialista aveva poi fatto epurazione della maggioranza moderata, seminando di sangue le strade della capitale. I nuovi padroni avevano scelto come bandiera un drappo rosso con due fasci littori incrociati contornati da una corona di alloro dorata e, ben presto, avevano proclamato la loro volontà di estendere la rivoluzione ai paesi confinanti.

Il primo obiettivo era stata la debole Olanda, occupata quasi senza colpo ferire nel breve volgere di un paio di mesi. La Prussia e l’Austria a questo punto erano intervenute, chiedendo il sostegno di Costantinopoli, anch’essa minacciata nei suoi themata francesi meridionali. Entrambe le potenze avevano ordinato la mobilitazione quando delle rivolte avevano scosso le rispettive capitali. Barricate e bandiere rosse erano spuntate in ogni angolo di Berlino e di Vienna, mentre sommovimenti simili scoppiavano in tutta la Germania confederale e in Ungheria.
Diversi reggimenti di riservisti si erano schierati con i ribelli, generando caos e incertezza nei monarchi, che abbandonarono le rispettive capitali scortati da guardie fedeli.
Questo stato di cose entusiasmò i francesi, che invasero il meridione della Francia. Napoleone II, distrutto dalla morte di tutte le persone a lui più vicine, rimase passivo e questa inazione portò i militari, guidati dal potente magister militum Theophilos Kantakouzenos, ad architettare un ennesimo colpo di Stato. Stavolta tutto venne organizzato per bene, ma il giorno in cui le truppe assaltarono il Palazzo Magnaura la popolazione insorse nuovamente, chiedendo pane e Costituzione. Era il caos più totale.
Napoleone II, per evitare ulteriori spargimenti di sangue e forse nel desiderio di togliersi dalle spalle una corona che aveva sempre trovato scomoda, abdicò. Non aveva figli, perciò indicò come erede il cugino Carlo Luigi Napoleone, figlio dello zio Luigi. Questi si era dimostrato un coraggioso soldato ed era apprezzato dai generali, che subito si schierarono dalla parte del nuovo sovrano.
L’imperatore appena salito al trono era anche un fine politico, e aveva in comune con il grande zio Napoleone I l’abilità di sentire il polso del popolo. Decise di dare perciò un colpo al cerchio e uno alla botte. Concesse una Costituzione identica a quella soppressa dal cugino pochi anni prima e al contempo adottò come titolo dinastico anche il nome di Konstantinos, tanto caro ai costantinopolitani. Il suo nome ufficiale fu, quindi, quello di Napoleon-Konstantinos I. Con tale stratagemma andava ad indicare, simbolicamente, un nuovo inizio, riallacciandosi al padre fondatore della capitale e, ancora meglio, riazzerando la numerazione grazie all’unione di due nomi di grande impatto.

La cura della personalità fu al centro di tutte le attenzioni future del basileus, che stabilì definitivamente l’obbligo di scrivere tutti i documenti ufficiali in greco e latino, ufficializzando il bilinguismo imperiale, con l’accorgimento che a questa doppia traduzione doveva aggiungersi una terza nella lingua dei popoli locali su cui andava applicata. Era il primo passo verso la grande riforma federale del 1868, che reggerà fino alla Grande Guerra del 1911-1915.
Il suo colpo da maestro fu poi la promessa di amnistia assoluta per tutti i rivoltosi e la promessa di una legge, poi onorata nel 1849, che fissava l’orario di lavoro alle 8 ore giornaliere. Un primato mondiale. Immediatamente i tumulti si placarono in città e Napoleon-Konstantinos poté armare una spedizione per cacciare i francesi dalla Gallia romana.
Ebbe anche l’accortezza di spostare legioni e cannoni anche a nord, dove rivolte simili erano scoppiate anche in Polonia, Russia e Ucraina, e minacciavano di dilagare anche negli Stati Clienti balcanici di Costantinopoli.
L’avvento di questa nuova guida sulla barca dell’Impero Romano sembrava aver cambiato la rotta pericolosa che era stata incautamente presa dal suo predecessore, ma le sfide erano appena iniziate.
Alberto Massaiu






Leave a reply